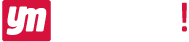Lo stesso Till Neuburg, per onorare la scomparsa dell’illustre storico dell’arte, gallerista, curatore e divulgatore mediatico, ci invita a rileggerlo così come pubblicato dal blog di Pasquale Barbella ‘Dixit Cafè’, ricordando che la cerimonia dell’ elezione nella Hall of Fame si svolse alla Videoteca Santa Sofia in via della Moscova, messa a disposizione dell’ADCI da Piero Maranghi, allora gestore del Centro.
Ci sono i Celebranti della Cultura con la C majestatis, scolpita in modo indelebile nel marmo della retorica (come in Chiesa, Chief Executive Officer, Costituzione, Champions League, Centro Commerciale, Carabinieri), e sull’atlante opposto abbiamo i complici, i causeur, i capitani di ventura che ci guidano con il loro infallibile navigatore elementare nella rete sempre piú intasata della cultura con la c caparbiamente piccina (come in conoscenza, classico, creatività, crossover, calembour, curriculum, comunicazione, cazzata, civiltà).
Un affabulatore che ama decifrare le lettere minuscole con le lenti molate da Spinoza, con gli occhialini rigorosamente tondi, con la messa a fuoco del minimalismo e della grandeur, decisamente non può avere la vista a miccia corta. E cosí, a chi piace scrutare il mondo dell’arte dal buco della struttura storiografica, un’audioguida visiva è sempre maledettamente comoda e seducente. Essere presi per mano, e qualche volta anche per i fondelli, da uno che sa «di tutto di piú», fa parte del Grand Tour che tutti quanti sognavamo, comodamente spaparanzati sulle poltronesofà di casa, de laFeltrinelli o dell’ennesimo vernissage.
Se poi un moderno erede di Marco Polo, di Bruce Chatwin o di Arthur C. Clarke, oltre all’opulenta diversificazione tematica ci regala anche il divertissement, allora si può tranquillamente sostenere che il petting tra informazione e formazione ha felicemente generato un nuovo dandismo meneghino che dopo Caravaggio, Marinetti e Arbasino dalle nostre parti non s’era piú letto né sentito, e men che meno condiviso.
Secondo Gillo Dorfles, «La persona veramente elegante è sempre un po’ démodé». Coco Chanel è ancora piú tranchant: «La moda passa, lo stile resta». E cosí il demi-monde rivoltato delle griffes (dove l’etichetta ha perentoriamente sostituito l’étiquette), la moda servile dei timer sopra il polsino, i completi all black da ignoranze funebri, le basette potate come le siepi di bosso di Versailles, le cravattone formato spinnaker firmate Prosciutto di Prada… tutta questa mascherata nouveau riche fa inorridire chi veste rigorosamente second hand oppure su misura. Per colmo dello scandalo, il nostro épateur indossa allegramente l’intera gamma Pantone, puntualmente valorizzata da un leggiadro papillon.
Vestire in modo comodo, fantasioso e personale non solo diverte di piú, ma non è trendy (quindi passé) e soprattutto, come diceva l’allegro aperitivo rosso in bottiglietta, «c’est plus facile».
Da anni ormai in Italia i curiosoni dell’antico, del vintage, del nuovo e del futuro che notoriamente non è piú quello di una volta, sono abituati – nel senso di habitué, di fedelissimi, di ultrà – alle seduzioni mediatiche di un sempre piú popolare immigrato del nord. In realtà il nostro Filippo di Francia detto il Bello, forse meglio conosciuto come citoyen Philippe Daverio (senza l’accento finale alla francese come in Platini oppure in Jean-Baptiste Lully aka Giovanni Battista Lulli), è nato dalle parti dei fratelli Goncourt, di Gustave Doré, di Alfred Dreyfus, di Albert Schweitzer, ma anche di Tomi Ungerer, di Marcel Marceau e di Jean Arp. Erano tutti, ça va sans dire, dei Galli combattenti in un pollaio di confine la cui linea di demarcazione non si sapeva mai se si trovasse al di qua o al di là del Reno.
Senza scomodare troppe metafore, con la sua sterile Linea Maginot una volta l’Alsazia fu il simbolo della disunione, mentre oggi ospita addirittura la capitale amministrativa del continente. Eppure – a parte i bretzel, la birra e i crauti alias choucroute – l’Elsass francofono aveva già attratto dalla riva opposta nientemeno che il futuro inventore della stampa a caratteri mobili: per ben diciotto anni il protestante Gutenberg bulinò in una bottega d’incisione presso la cattolicissima Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg.
Quasi mezzo millennio dopo, a soli 20 km dalla capitale renana, a Molsheim, la regione adottò un altro genio della mobilità: il piú «veloce» designer milanese dell’epoca. A una recente asta Sotheby’s, un suo capolavoro catalogato con il perentorio titolo Bugatti Royale è stato battuto a quasi cinque milioni di euro – piú o meno il prezzo di una scultura di Brâncuşi, Giacometti o Henry Moore.
In tema di quotazioni, Daverio la sa parecchio piú lunga e piú in profondità di tanti artisti e collezionisti che si trastullano nelle P.R. sotterranee e nei caveau. Dalle parti dell’Hudson River e dei Navigli, ha inaugurato e gestito ben quattro gallerie, una libreria d’arte e una casa editrice. A Milano ha rilanciato il Palazzo Reale, collaborato energicamente al recupero del Piccolo e del Teatro dell’Arte alla Triennale, alla genesi del progetto Ansaldo e infine alla nascita dell’Arcimboldi di Vittorio Gregotti.
Gli architetti moderni che hanno marcato alcuni angoli di Milano, Daverio li vede e li vive come preziosi conniventi. Da quando l’egemonia napoleonica fallí nel tentativo di spezzare lo sviluppo urbanistico circolaredei bastioni e dei navigli (Corso Sempione non ce l’ha mai fatta a riproporre la grandeur degli Champs-Élysées), la città si è rannicchiata in sé stessa. Eppure, prima di Gregotti, Zanuso, Gardella, Aulenti, Aldo Rossi, a Milano avevano lasciato i loro segni non solo i titani Terragni, Lingeri, Ponti, il gruppo BBPR e Portaluppi, ma anche i vari Asnago, Boito, Borgato, Latis, Moretti, Muzio, Vender.
Proprio questi ultimi si «ritrovarono» nella magnifica sede della Fondazione Piero Portaluppi quando Daverio presentò una mostra del visualizer «razio-metafisico» Marco Petrus. Un paradosso che Daverio commentò con dovizia/malizia inarrivabile attraverso un ininterrotto excursus storico-urbanistico di un’ora: che di tale levatura, prima di allora, avevo sentito solo da gente come Umberto Eco, Jacques Le Goff, Edward Tufte, Federico Zeri.
Se per la storia dell’arte proprio Zeri è stato – per scelta, sventura e vanità – il piú celebrato degli anti-italiani (nella sua casa a Mentana, saputo che ero di origine straniera, mi rassicurò secco: «Amo l’Italia e odio gli italiani»), Daverio invece assomma in sé tutte le qualità del playmaker che gioca sempre per la squadra – ovvero, in ultima analisi, per noi. A seconda della stagione, dell’arena e di chi lo insegue, Daverio è, di volta in volta, regista – souffleur – navigatore – cultural trainer – cicerone – guest lecturer – traduttore – lucciola – maestro – conducente – esegeta – precettore… Ma qualche volta – quanno ce vo’ – semplicemente sfidante e agitatore il quale, come clava piú micidiale, agita di preferenza lo sfottò.
In un paese che, secondo le statistiche dell’Unesco, detiene una cinquantina dei 725 siti del World Heritage culturale, la storia dell’arte diventa eo ipso la storia tout court. A cominciare dal Vasari, i piú acuti estensori delle nostre mappe politiche, militari, economiche, scientifiche e persino gossippare sono stati spesso gli storici dell’arte. Adolfo e Lionello Venturi, Roberto Longhi, Carlo Ludovico Ragghianti… senza dimenticare il léttone naturalizzato Wasp Bernard Berenson, che per i suoi «ultimi» sessant’anni scelse saggiamente di acquietarsi sopra le colline di Firenze.
Il contesto nel quale Daverio mantiene, appunto, acceso quel cerino, è quello che va sotto il motto aristocratico di non-specializzazione. Chi cerca di capire cosa diavolo bolle nel pentolone che – nel menu fisso dei convenevoli e dei convegni – si usa circoscrivere con la parola «comunicazione», non si orienta certo sui libri di testo, sulle notizie Ansa e sui telegiornali. Saper leggere tra le righe della storia sottaciuta, dei simboli a volte criptici e persino della piú smagliante inattualità, è un mix che attraverso gli sguardi e il labiale di Daverio in noi si trasforma subito in complicità, in vivida passione, in adolescenziale verve.
Il suo potere seduttivo è semplicemente sconcertante. Con lui, gli addetti si trasformano inesorabilmente in addicted. Se lo conosci, non lo eviti.
Come succede dappertutto, anche in Italia ci sono cronisti e cantori indissolubilmente legati a luoghi, moduli e modelli: parlando, per esempio, di paradossi sublimi, non puoi che pensare ad Altan; se citi Washington D.C. ti riferisci per forza agli spaccati antropologici di Vittorio Zucconi; il mondo incompreso e complesso della non-violenza nazionale è legato a Danilo Dolci; se parli in modo appassionato del Tour de France, Gianni Mura è il tuo uomo; se scruti i cieli per oscurare l’astrologia, consideri automaticamente Margherita Hack; se cerchi la compagnia di un giocoliere delle parole, non puoi che inciampare in Stefano Bartezzaghi… E cosí, se vuoi incocciare in un Harry Potter che conosce ogni soffitta, nascondiglio e spiraglio dell’arte dove soffia la brezza della curiosità, allora il tuo Gentil Organisateur è colui che ha in tasca la chiave per aprirti qualsiasi spioncino e portone: per un intero decennio, Passepartout non è stato affatto un badge né un rito divinatorio e tanto meno una password misteriosa… ma una cosa molto piú semplice – e piú articolata.
Nel mondo dei media, abbiamo avuto dei «formati» (formati come in formato famiglia, tascabile, oversize, A4, extrasmall, Adobe… perché Daverio detesta i «format» tanto cari ai palinsestanti della tivvú), dove l’accessibilità, la modestia, lo stile dialogante sono sempre stati i valori vincenti: Non è mai troppo tardi, Il Circolo Pickwick, Viaggio lungo la Valle del Po, Chiamate Roma 3131, Sottotraccia, Quark, Per un pugno di libri, Il fatto, Le storie, Report, Che tempo che fa, L’infedele, ma anche Rischiatutto, Bandiera gialla, Tutto il calcio minuto per minuto, Specchio segreto, Quelli della notte, L’ottavo nano. Programmi diventati tutti popolari malgré eux. Senza indici, sopraccigli e crocifissi alzati; i toni sempre distesi; scatarrare ex cathedra, tabú.
Però: tutti questi formati di successo sono stati – e sono – pensati, presentati e commentati da due, da alcune o da una moltitudine di persone. Passepartout, invece, è sempre stato tassativamente un one-man show. È stato un reiterato salto nel buio, lontano dai colpi di sole dell’Auditel, che è riuscito a pochi. Qualcuno, come il sindaco di Salemi, provando a compiere un’arrampicata solitaria sulla parete nord di Saxa Rubra ci ha rimesso le penne – non solo quelle all’arrabbiata egoriferite, ma anche quelle che servono a firmare i contratti con le emittenti tv.
Per motivi giuriburodemenziali, alla fine dell’anno scorso Passepartout è stato discretamente sfilato dal portachiavi di mamma Rai. Ma siccome i voli di Daverio non si erano mai svolti a livello di basso impero, i suoi vecchi looping in alta quota vengono continuamente riproposti alla tv deliziando chi ama le giravolte dell’intrattenimento e dello share.
Piú o meno un anno prima s’era concluso un ciclo tematico per viandanti immaginari, sempre ideato e firmato Daverio. Su Rai 5, il nostro cicerone ci accompagnò in una dozzina di luoghi ameni: di quelli che il Guide Michelin di qualche tempo fa avrebbe sicuramente corredato con il classico uccellino e la civettuola precisazione «Vale una deviazione». Insieme a Siena, Mantova, Ferrara, Orvieto e Bologna, Daverio ci faceva scoprire i tesori gelosamente seminascosti di Bassano del Grappa, Conegliano, Busseto e Aosta nonché alcune aree particolarmente popolari come i laghi lombardi, il biellese e il Tirolo; luoghi che credevamo di conoscere bene, se non addirittura come le nostre tasche. E invece no: in quelle dodici saccocce virtuali dei nostri jeans andarono a infilarsi, a nostra colpevole insaputa, capolavori e monili che non ci saremmo aspettati di possedere nemmeno dopo una scorreria nei piú ricchi musei.
Ma per fortuna, nostra e della Rai, a partire dall’8 gennaio di quest’anno Daverio è nuovamente presente sul terzo canale, questa volta con un programma dal titolo provocatoriamente proto e post marxista: Il Capitale. Il ciclo approfondisce, fin dentro le viscere della socialità, il metabolismo della ricchezza reale: non i soldi ma l’inventiva, l’immaginazione, la fantasia – tutto quanto nel gergo gazzettaro, modaiolo e reclamista è shakerato con la ten-letter word, «creatività».
Il contorno scenografico della trasmissione è già di per sé un programma. Alle sue spalle appaiono banconote di tutto il mondo: i volti che vi sono raffigurati, come sappiamo, appartengono spesso a personaggi storici della cultura e della scienza – non certo ai maestri del denaro come i vari Medici, Fugger, Rothschild, Keynes, Carli, Galbraith, Friedman, Thyssen, Vanderbilt, Rockefeller, Getty o Agnelli. Quella galleria è lí a segnalarci un autentico trompe-l’œil del potere: un facebook della finanza Potëmkin, un dolciastro identikit millefoglie che a ogni sfregamento tra indice e polpastrello ripropone la favola del do ut des, dei bilanci certificati, della legge del mercato, di quella Cultura, in questo caso persino con la doppia C maiuscola (come in Conto Corrente), che si tramuta sempre piú spesso in Cash, in Capital gain, nell’onnivora, ubiqua e devastante Crisi che aumenta in modo esponenziale i chicchiricchi nelle risaie dei super ricchi.
Fu proprio un’altra crisi quella che, nel lontano 1993, un solo anno dopo tangentopoli, portò Daverio ad esercitare non piú solo l’autorevolezza culturale, ma anche quella politica e amministrativa. Il primo e unico sindaco leghista di Milano, Marco Formentini, lo imbarcò nel suo governo cittadino perché il precedente assessore alla cultura, nelle amministrazioni di Pillitteri e Borghini, aveva lasciato nient’altro che qualche sbiadita impronta da yeti, subito cancellata.
Per Daverio furono quattro anni belli, difficili, intensi. Eppure, a differenza di ciò che avvenne alla maggioranza dei colleghi, per quanto riguarda i suoi bilanci personali quell’esperienza finí persino per danneggiarlo. Il suo proverbiale attivismo professionale fu quasi completamente assorbito dall’agenda delle iniziative e degli eventi pubblici.
Ma, non appena rientrato nella «normalità», Daverio non ci ha fatto mancare niente: libri, lezioni, mostre, docenze, prefazioni, documentari, presentazioni, dibattiti, collane, interviste, sono tornati a riempire ogni piú remoto spazio della sua agenda. Oltre ai nomi già citati (ed escludendo le centinaia di persone e siti coinvolti per Passepartout), ecco una piccola selezione random dei complici viventi e degli eventi che Daverio ha fisicamente toccato e coinvolto in questi anni:
Amadeus, Art’è, Alessandro Bergonzoni, Biennale di Venezia, Achille Bonito Oliva, BonOmnia, Mario Botta, Classica, Festival del Racconto di Carpi, Il Corriere Musicale, Corriere della Sera, Fabio Fazio, Feltrinelli, Festival della Creatività, Massimiliano Fuksas, Giunti, Iulm, Milano Film Festival, Notti Cangianti Roma, Palazzo Fava Bologna, Facoltà Architettura Palermo, Panorama, Pierlombardo, Politecnico Milano, Pomeriggi Musicali, Fondazione Portaluppi, Enrico Rava, Repubblica, Rizzoli, Salone del Mobile, Casa Saraceni, Saturno, Scala di Milano, Skira, Toni Servillo, Il Sole 24 Ore, Claudio Strinati, Collezione Tagliavini, Spazio Thetis, Vogue…
È un elenco ridicolmente incompleto, ma l’abbiamo compilato lo stesso, tanto pe’ cantà l’inno della non specializzazione, che con Daverio tocca forse le note piú alte del repertorio del divertissement, popolare, dialogante, colto.
In tema di inni, contrappunti, liriche e pentagrammi, non possiamo fare a meno di scatenare una standing ovation per la bacchetta magica che Piero Maranghi, del canale Classica, gli ha affidato per dirigere Music Book Gallery, una collana di libri corredati ciascuno da 2 cd, dedicata ai capolavori piú elevati della lirica, della concertistica, della letteratura, della ricerca in ambito musicale. Il repertorio spazia da Händel a Boulez; gli interpreti comprendono, tra tanti altri, Karajan, Barenboim, Zubin Mehta a Riccardo Muti. Chiedere il bis di quel repertorio tanto ben concepito ed eseguito, è un puro dovere e piacere.
Tra i tanti libri e cataloghi non legati alla musica, che Daverio ha pubblicato in questi anni (sono ormai oltre la cinquantina) per vari editori, ci piace soffermarci su quello uscito alla fine del 2011 da Rizzoli.
Il museo immaginato non s’ispira alla ricerca Proust’s Imaginary Museum di Gabrielle Townsend, né tanto meno al citatissimo Musée Imaginaire inaugurato esattamente mezzo secolo fa a Le Havre dallo scrittore maudit e ministro gollista della cultura ancora piú malignato, André Malraux. Il museo di Daverio non è un excursus «museale», ma una scorreria, un’incursione irrispettosa nel bon ton accademico – per rubacchiare, combinare, mettere insieme una collezione del tutto personale.
Per attuare al meglio il suo raid, Daverio procede per esclusione: 1) sistemare i quadri in ordine alfabetico, sarebbe da idioti; 2) seguire una sequela cronologica, saprebbe tanto di statistica, o peggio, di database; 3) separare e organizzare le opere per scuole, stili, correnti, ricorderebbe in modo atroce i quiz da circolare ministeriale, da primo della classe o, peggio, da vecchio prof tendenzialmente bollito. Pertanto, non rimane che organizzare la refurtiva per ambienti (entrata, salone, studio, cucina, camere, scale, corridoi) e rapportare le opere – affettuosamente e arbitrariamente – tra loro. Per temi, per oggetti, per circostanze, per persone, per relazioni.
Chi «vive» in un museo cosí non intende dimostrare nulla. Non segue percorsi obbligati. Ma soprattutto – e questo sarebbe il valore in assoluto piú prezioso – non ha fretta. Per capire un quadro, lo devi guardare. Studiare. A lungo. Non avere fretta per capire l’arte sembra un’inquietante ovvietà, eppure per-correndo, comme d’habitude, i musei, non facciamo altro che praticare un’infinita e stancante successione di sveltine.
Gli yankee dicono: «Time is money». Anche per Daverio il tempo è prezioso, ma i malebenedetti bucks, i verdoni, i bigliettoni con sopra i loro Presidenti, non a caso, lui li ha messi alle sue spalle – come metafora nel suo Il Capitale, concretamente perché da parecchi anni abbiamo già dato. E ricevuto.
Merci, mon cher Philippe.
© Till Neuburg / Skira 2012.