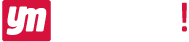di Maurizio Ermisino
Tommaso Basili è un attore che, appena senti il suo nome, non associ immediatamente a un volto come accade per certe star del cinema. Ma non appena vedi una sua foto, un frame, il suo volto, immediatamente capisci di conoscerlo bene, di averlo visto, e apprezzato, molte volte. È da questo spunto che abbiamo iniziato la nostra intervista a questo attore affascinante, in grande ascesa, che sta lavorando in produzioni internazionali. Tommaso Basili è stato Gianni Agnelli nell’ultimo film di Michael Mann, Ferrari, ha recitato in Here After – L’aldilà, horror psicologico uscito da noi in estate e ora negli Stati Uniti. E ha girato, con un ruolo da co-protagonista una serie prodotta, co-diretta e presentata da Martin Scorsese. Martin Scorsese Presents: The Saints. Parlare con Basili significa davvero capire il lavoro dell’attore.
Come si vive quel momento in cui il nome non è associato immediatamente a un volto, non si è delle star, ma si sa di essere nei progetti che contano?
Mi sento come all’interno di un videogame: finita una sequenza ne comincia un’altra con altri problemi. Ho cominciato tardi a studiare recitazione, a 31, oggi ne ho 43. Mi sono imposto di non dirlo a nessuno, volevo capire se avevo le corde per almeno tentare di fare questo lavoro. Finito lo step dello studio, mi chiedevo: lavorerò mai? Avrò mai una battuta nei film? E poi: avrò mai due battute? Un ruolo rilevante? La vivo in maniera agrodolce: ringrazio l’universo, la fortuna e il duro lavoro di essere dove sono. Sono un attore che lavora, sono più che consapevole di essere a metà strada. Se guardo indietro devo essere felice; se guardo avanti e vedo i miei colleghi, persone come Stefano Accorsi che tutti sanno chi è, c’è ancora strada da fare. Quando diventi un nome poi cominciano altri problemi, come mantenere quello status. È una professione per cui volendo siamo votati alla frustrazione. Diventare un nome associato automaticamente a un volto non è proprio un mio obiettivo.
La formazione a New York cosa le ha dato?
La formazione in Italia – con coach non italiani – è stata fondamentale, ma era troppo basata sulla sofferenza. L’America ha un approccio completamente diverso: stiamo facendo un lavoro serio, fare palestra per gli attori è fondamentale, ma non dimentichiamo di divertirci; estrema serietà attraverso il gioco. Ho affinato l’inglese. Gli americani, oltre a dedicarsi all’arte, ti fanno capire che è un’industria, devi avere una collocazione per essere spendibile. In Europa, in Italia, si parla d’arte in maniera un po’ snobistica, ci sentiamo dei folgorati, dei prescelti. Ma il nostro è un mercato, un’industria e ognuno di noi deve trovare un proprio collocamento.
Come è stato suo esordio è stato in 1993, la serie Sky Atlantic su Tangentopoli?
È stata una piccola partecipazione, che tanto piccola non era: arrivavo a già 35 anni, mi chiedevo se potessi passare dalla teoria alla pratica, se ci fosse un mio spazio lavorativo. Era un mondo molto interessante, una serie ambientata negli anni 90, in cui ero piccolo. Mi sono avvicinato a Stefano Accorsi, a Miriam Leone, persone che vedevo come già arrivate, e la cosa mi è piaciuta: è importante per noi attori smitizzare alcune cose, non sminuirle, ma avvicinare le persone, sentirli dei colleghi.
Che esperienza è stata la serie Sky Diavoli?
Diavoli è successo molto dopo, è stata una bellissima esperienza: lavoravo molto con la Lux Vide, e avevano visto che so recitare in inglese. Il mondo della finanza non mi appartiene, e per questo mi ero fatto dei problemi: ma ho capito che era una serie poteva trattare d’altro e funzionare ugualmente. Sono della scuola che pensa che studiare sia importante, che i metodi siano importanti, ma alla fine il nostro lavoro è essere credibili all’interno della finzione. Come ci arrivi ci arrivi, ma l’importante è arrivarci.
Che esperienza è stata la serie Netflix Odio il Natale?
Mi sono trovato molto bene: all’inizio ero terrorizzato perché la commedia era una cosa che non avevo mai affrontato. Mentre nella commedia anglosassone non sei tu a dover essere divertente, ma sono le circostanze, in Italia siamo più noi attori a dover far sorridere. Siccome non è mai stata uno dei miei punti di forza, ero terrorizzato. Ma è andato bene. Quando sei supportato da un gruppo così è facile.
È stato Gianni Agnelli nell’ultimo film di Michael Mann, Ferrari. Come è riuscito a entrare nel personaggio?
Ho cercato di capire i punti in comune tra me e l’Avvocato e di lavorare su quelli. Di fare una copia esatta del personaggio non mi interessa e non ne sono capace: non si trattava di un biopic ma di una rappresentazione, e non ero tenuto a fare come Rami Malek con Freddie Mercury. Gianni Agnelli aveva delle cose che aveva mio padre: era un uomo del Novecento, aveva quel tipo di signorilità, quel tipo di portamento, quel mondo di parlare che non sottintendeva mai la fretta. L’Avvocato Agnelli aveva due particolarità: la gestione dello spazio, che faceva suo con un’eleganza incredibile; e sembrava lui a gestire il tempo e non il tempo a gestire lui. Ho cercato di lavorare sulla gestualità, su una calma, su un’eleganza. La mia scena clou era da seduto e la maggior parte delle interviste di Agnelli sono da seduto. Credo che se Gianni Agnelli fosse solamente una sagoma nera, seduto, da lontano, su un divano, ti renderesti conto che è lui.
Come è Michael Mann visto da vicino?
È molto meticoloso. Abbiamo girato la scena in due tempi: prima solo su Adam Driver al telefono e poi su di me. Mann è un signore. È alla mano, ma riservato, ha un’energia fuori dal comune. È preciso, un cesellatore, un compositore di mosaici. Ha bisogno di quanti più tasselli possibile per comporre la sua immagine. Quando ti fa rifare una scena 50 volte non è mai perché non è buona la prima, ma perché ha bisogno di un colore leggermente diverso. Ha fatto dire 50 volte le battute anche ad Adam Driver, che è bravissimo. È sempre presente, non al monitor, ma appena fuori campo.
Che esperienza è stata Here After – L’aldilà?
Per me ogni set è una scuola, ogni volta si riparte da zero. Sono due-tre anni che lavoro spesso con gli anglosassoni, hanno un modo di lavorare che mi piace e imparo sempre. Il thriller/noir/horror non lo conoscevo, richiede note di un certo tipo. La protagonista, Connie Britton, è un mostro di bravura, lavora in un modo mai visto prima e i risultati si vedono. Il film è uscito il 13 settembre in 1000 cinema, distribuito da Paramount.
In che ruolo la vedremo nella serie di Martin Scorsese, The Saints?
È una serie in diversi episodi, ognuno è un film a sé stante. Quando sono arrivato in Marocco, mi sono spaventato. Ho detto: se il livello di impegno va in parallelo a questi set, aiuto. C’era un caldo atroce, ma una motivazione enorme. I set sono epici, talmente belli che sei già nella parte. Scorsese lo abbiamo visto poco, non era presente fisicamente: lo vedevamo sull’iPad, collegato da remoto, vedeva tutti i girati. È stato lui a scegliere ognuno di noi. La serie ha una scrittura sublime: quando ho letto il primo provino, per quanto difficile, mi sono detto: come faccio a imparare questa cosa? È scritto in un inglese epico. Siamo nel 300 d.C., e l’episodio è quello di San Sebastiano: io sono il cattivo, il coprotagonista. I primi 4 episodi andranno in onda in Usa a novembre, su Fox Nation. Non si sa ancora dove, ma la serie arriverà anche in Italia.
Cosa cambia quando si rapporta a un progetto internazionale rispetto a uno italiano?
In un progetto internazionale è leggermente diverso: noi italiani siamo bravissimi e inventarci soluzioni, gli stranieri fanno in modo che non ce ne sia bisogno. Il modo di lavorare è lo stesso. Forse tra noi italiani c’è più empatia. Per gli americani è un’industria. Ognuno ha il suo ruolo, siamo tutti sulla stessa barca e cerchiamo di portare a casa il risultato.
E tra una serie per una piattaforma o un set per il cinema?
Non è tanto se un’opera va in tv o al cinema. È più una questione di personaggi: alcuni richiedono poco lavoro, alcuni molto. È questo che le scuole non fanno: ti vogliono insegnare ad essere un bravo attore, un modo per esserlo. Ma non c’è un solo modo di recitare: devi capire per quale tipo di progetto, di scrittura, di mondo stai lavorando. Anni fa feci una serie americana per Netflix, che richiedeva un tipo di recitazione che se l’avessi fatta per un altro prodotto mi avrebbero mandato a casa. Uno prima capisce il personaggio, se è vicino a sé o se è lontano. E poi quale tipo di linguaggio richiede: essere sopra le righe o sottotono. Se richiede che tu faccia vedere allo spettatore le cose, cioè una recitazione indicativa, o invece protratta verso la tua interiorità. Serie come Odio il Natale richiedono che tu sia didascalico nel far vedere a chi guarda come stai: chi guarda non deve pensare. Ci sono altri film in cui è il contrario, può esistere un’ambiguità e sta a te spettatore decifrarla.