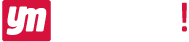Tornare in ufficio almeno otto volte l’anno, questo si attende l’ex-startup Canva, nata nel 2013 e attiva nell’ambito del graphic design, che ha aggiornato le proprie linee guida rispetto allo smart working. Sul sito la società scrive che con la globalizzazione e il lavoro online sono emerse nuove necessità per i luoghi di lavoro sia sul fronte dei processi, sia su quello della produttività e del lavoro di squadra. “Un adattamento rapido ed efficace è necessario per il bene sia dei dipendenti sia dei datori di lavoro”, è la conclusione.
Canva si concentrerà sulla flessibilità e la connessioni tecnologiche superando nei prossimi mesi l’obbligo di presenza in ufficio. Una rivoluzione per gli oltre 1.700 dipendenti dell’azienda, che potranno sperimentare dal vivo, in maniera strutturata e non più in emergenza, quando hanno espresso in un sondaggio interno: 79% dei lavoratori ha dichiarato di sentirsi produttivo lavorando da casa, con l’81% che ha detto di voler continuare a bilanciare il lavoro in ufficio con il lavoro a distanza.
Il diavolo, comunque, è sempre nei dettagli: l’indicazione di una durata minima del lavoro onsite e l’assenza di un massimo potrebbe voler dire, estremizzando il concetto, che ci sarebbero teoricamente centinaia di dipendenti a cui verrebbe richiesto di essere presenti tutti i giorni, a fronte di ‘pochi’ privilegiati che potrebbero lavorare da casa, o da qualsiasi altra parte del mondo, quasi tutto l’anno, fatto salvo il periodo minimo richiesto di presenza in ufficio.
Ma vediamo come viene affrontata nel mondo questa situazione, e con la parola ‘mondo’ intediamo gli Stati Uniti, la sede di ‘tech giant’ che governano il versante digitale delle nostre vite. La situazione non è confrontabile con gli omologhi cinesi, i futuri dominatori dell’arena, dove la formula 996, 12 ore lavorative al giorno, sei giorni alla settimana, viene ora contestata – per ragioni squisitamente politiche, ma questo è un altro discorso – dallo stesso PCC, il potente e pervasivo Partito Comunista Cinese.

Negli USA, invece, si è riscontrata una ‘rivolta’ dei dipendenti contro il ritorno per tutti in ufficio. Rivolta che, complice la variante Delta del Covid, è stata temporanemente sedata: il back-to-office è stato rinviato ai primi giorni di gennaio 2022, da parte dei due colossi Apple e Google, cui si stanno adeguando anche gli altri.
Apple, sin dal primo lockdown di marzo 2020 ha invitato i propri dipendenti a svolgere le loro mansioni da casa, sperimentando forme di lavoro in gran parte inedite (almeno in queste proporzioni) anche per una grande azienda come quella di Cupertino. Al primo allentamento della morsa del virus, però, il CEO Tim Cook ha gradualmente richiamato i dipendenti in ufficio, pur nel rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria e del buon senso. Ma i dipendenti hanno fatto sentire la loro voce, manifestando la volontà di continuare a lavorare da remoto anche in futuro, dunque oltre i tre giorni a settimana garantiti da Apple.
Google (o meglio Alphabet, ma ci vorrà non poco tempo perché questa definizione prenda piede) aveva inizialmente pianificato un rientro parziale in ufficio, scaglionando la frequenza con cui le persone sarebbero andate in sede e riducendo la densità abitativa dei suoi spazi, ridisegnati con nuovi model design, che rivoluzionavano i paradigmi cui si erano tutti abituati. Ora l’approccio è più pragmatico: come diceva James Gorman, il CEO di Morgan Stanley, ai dipendenti della sede newyorkese: “Se si vuole uno stipendio da New York, si deve lavorare a New York”. Google rovescia il concetto e vuole pagare i dipendenti in funzione del costo della vita del luogo dove risiedono, con tagli alla retribuzione fino al 15%, o addirittura al 25%.
Una scelta del tipo: ‘tu scegli di lavorare da casa e io ti pago in proporzione al costo reale della vita, non è più una questione di produttività’. I risparmi si aggiungerebbero a quelli derivanti da meno viaggi e spostamenti dei dipendenti, e azzeramento della attività per fiere e manifestazioni.

Una scelta, questa, che potrebbe essere adottata anche da Twitter e Facebook: il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha lasciato i dipendenti liberi di lavorare “dove si sentono più creativi”, e la stessa cosa, più o meno, ha ripetuto anche Mark Zuckerberg, a capo di Facebook, che ha annunciato che la sua sarà “l’azienda più orientata al futuro sul lavoro a distanza”. Ma entrambe le aziende vogliono essere informate su dove risiedono i loro smart worker. “Ci saranno gravi conseguenze per le persone che non sono oneste su questo aspetto”, ha minacciato Zuckerberg.
Assumere chi ha le competenze giuste e vive in aree a basso costo della vita, insomma, potrebbe diventare più conveniente per le aziende. Un aspetto che potrebbe portare a mutamenti sostanziali anche nel mercato immobiliare, con le grandi e costose città a perdere di appeal dopo la rivoluzione del lavoro da remoto. Al contrario, aree attualmente meno appetibili potrebbero beneficiare del nuovo orientamento delle multinazionali. Anche in altri paesi, al di fuori degli Stati Uniti.

E poi resta il problema dei monumentali Head Quarter della aziende, con l’HQ della Apple, ad esempio, costruito con una spesa di 5 miliardi di dollari nel 2017 e praticamente deserto da un anno a mezzo.
Capitale contro lavoro, lo scontro questa volta è sullo ‘smart working’, e può assumere anche contorni paradossali come mostrano le dichiarazioni di Sundai Pichai, CEO di Google e di Alphabet: “i dipendenti vengono in ufficio per risolvere problemi in un bar, attorno a una lavagna o durante una partita di beach volley o cricket”.
In futuro sarà quindi la volta degli eSports, per continuare a rimanere in smart working?