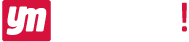Un’esperienza pluriennale in agenzie blasonate, lavorando a fianco di grandi creativi, da cui ha imparato i dogmi di laicità e disobbedienza. Pur ammettendo “ieri era tutto più facile”.
Vincenzo Vigo. Un pubblicitario, perché, come dici tu, questo sei, poi ci sono i bravi comunicatori, ma a te piace parli di più il lavoro. Un trascorso in agenzie importanti, da Leagas Delaney, Young&Rubicam, Red Cell e Armando Testa, fino alla creazione della tua Mosquito e contemporaneamente l’attività come consulente. Proviamo a mettere in fila tutti questi tasselli, come coniughi le tue scelte rispetto a quelle che oggi sono secondo te le necessità di brand e aziende?
Il percorso professionale che ho fatto fin qui rispecchia la mia curiosità e anche il mio carattere. Ho lavorato in grandi agenzie, italiane e internazionali, e ho avuto la fortuna di incontrare eccellenti professionisti. Altri bravissimi colleghi li ho conosciuti fuori dal lavoro e scambiare idee ed esperienze anche con loro è stato altrettanto importante. Ho deciso di lasciare una direzione creativa e di sede di una grande agenzia alla fine del 2011 per un semplice motivo: non vedevo più orizzonti davanti a me. O meglio, non quelli che io desideravo per la mia evoluzione. Mi intrigava l’idea di mettermi alla prova come imprenditore e, contemporaneamente, di ritornare “a bottega”, luogo in cui la cura e la passione per il lavoro potessero essere di nuovo rilevanti, se non addirittura decisive. Con questa idea è nata Mosquito, una sigla outsider per vocazione, ma con un’impostazione professionale e strategica che poteva beneficiare delle esperienze maturate nei grandi network. Una volta un cliente mi ha detto: voi siete come il bonsai di una grande agenzia. Mi sembra una definizione calzante, che rispecchia questi tredici anni di lavoro per clienti come Molinari, Crai, Monari Federzoni, Acqua Lete, BigMat, Erreà, Intralot, Cantine Banfi, Università Ca’ Foscari, Acqua Sant’Anna, PiùMe, Pasta Mancini e, adesso, Gruppo Montenegro. Con loro ho iniziato un percorso consulenziale: una sfida entusiasmante, un nuovo stimolo per evolvere e completare la mia figura professionale. Poter contribuire a una visione globale e alle strategie della comunicazione di un gruppo dalla storia e dai valori così importanti non farà altro che accrescere le mie motivazioni. Anche questo è un segnale di ciò che oggi cercano le aziende: rapporti diretti e veloci, non inficiati da riti, burocrazie e dispersioni di energie. In un mercato sempre più globale e paradossalmente più frammentato c’è bisogno di più competenza, attenzione, cura del particolare e, a volte, anche di un sano spirito critico. Le strutture indipendenti (e che in ogni caso non dipendono da logiche squisitamente finanziarie) sono, in prospettiva, le più avvantaggiate. Concludo dicendo che da sempre sono convinto che il miglior ambasciatore di sé stessi sia (o dovrebbe essere) il nostro lavoro. È uno specchio che riflette fedelmente tutto ciò che abbiamo fatto, senza rischi di distorsioni o infatuazioni di sorta.
L’abbiamo detto, ti confà un ruolo understatement, eppure di cose da dire ne hai, soprattutto alla luce di un mantra: ‘fare una pubblicità che disubbidisce a sé stessa’. entriamo nel merito delle sue implicazioni?
L’understatement, a pensarci bene, potrebbe anche essere visto come una forma di esibizionismo. Dunque, preferisco non essere catalogato tra coloro che lo praticano a tutti i costi. Non è questo il punto. Dico solo che essere creativi è un fatto interiore, dipende da come siamo fatti, da ciò che abbiamo assorbito e dalla nostra curiosità, non (solo) da ciò che siamo capaci di esternare. Il mio mantra “fare una pubblicità che disubbidisce a sé stessa” è nato da un’osservazione. La comunicazione da un po’ di tempo sembra avere paura della sua stessa ombra, si rifugia nei cliché, usa parole che periodicamente diventano di moda (l’inflazionatissimo “iconico” su tutte) tende ad omologarsi, anche tra generi diversi. Diventa, insomma, sinonimo di conformismo. E invece dovrebbe essere tutto il contrario. Prima di sedermi davanti al cosiddetto “foglio bianco” studio sempre cosa fanno i concorrenti del mio cliente. Ma non tanto per prendere ispirazione, quanto per capire in che modo possa discostarmi da strade già battute e costruire un linguaggio sempre distintivo e dunque più efficace. La comunicazione deve emozionare, innovare quando è possibile, far riflettere ed essere ricordata. Perciò deve avere coraggio, profondità, capacità di osservazione, e a volte – quando serve – anche della sana sfrontatezza.
Inutile negarlo, il rischio per la comunicazione contemporanea è non arrivare. Troppi messaggi, troppo rumore, tanto conformismo. Qual è il tuo approccio per superare il conformismo a favore di idee e creatività che siano fatti intellettuali non outfit?
La comunicazione oggi ha le pallottole spuntate un po’ per i motivi che ho detto prima, ma non solo. Spesso è il risultato di compromessi che ne attutiscono l’efficacia. Della voglia di seguire a tutti i costi il cosiddetto filone del “politicamente corretto”, tralasciandone altri inesplorati come il “politicamente lieve”, il politicamente “divertente” il “politicamente ironico” e così via. Oppure, altre volte è frutto di una errata valutazione della capacità cognitiva dei consumatori. Spesso, troppo spesso, si tende a considerarli poco evoluti dimenticandosi, per esempio, che oggi chiunque è capace di creare contenuti ed è esposto quotidianamente a migliaia di stimoli verbali e visivi. Senza nulla togliere ai cosiddetti (e certamente geniali) padri della pubblicità italiana, credo che il lavoro di chi oggi riesca a proporre messaggi memorabili, originali e che sappiano innescare dialogo sociale meriti più attenzione rispetto a quello di chi operava su memorie vergini, con cinque spazi pubblicitari a sera. Nell’epoca del digitale la memoria collettiva si resetta ogni due o tre mesi. Negli anni ’60 e ’70 non era certamente così.
La comunicazione che vale è quella che regge nel tempo. Ci fai degli esempi di tuoi lavori che ci sono riusciti?
Le campagne che durano nel tempo sono quelle che sanno “pescare” nella realtà. Che facciano scattare l’autoidentificazione e che abbiano quei “semi” per rimanere impigliate nella memoria collettiva. Creare dei format aiuta certamente a questo scopo, a patto che ci sia una strategia che li sostenga. Tra le campagne realizzate (oltre 600) che mi piace ricordare ci sono, oltre all’ultima per l’Amaro Montenegro, il “Denghiu” ideato per De Agostini con Aldo Biscardi (campagna uscita una sola settimana nel ’97 e ancora oggi fa la sua parte come tormentone), la saga dell’uomo invisibile per la Sambuca Molinari(prima con Luca Ward e poi con José Mourinho), lo spot per Rauch Bravo, ingiustamente censurato, e lo “Human Rights ideato per UTET; il format Crai in animazione e 3D (on air per sette anni), la campagna “New York” per il lancio di BMW serie 3, e infine quella del jumper Luca Matteo Ferrari, che si lancia dalla terrazza di un grattacielo per assaggiare il Barattolino Sammontana dei suoi coinquilini che abitano parecchi piani più giù. A questo spot, nato nel 1995, sono molto affezionato. Per circa un mese (una volta c’era più tempo per pensare) io e il mio art Antonio Cortesi non eravamo riusciti a trovare nessun’idea che ci convincesse davvero ma, rileggendo il brief per l’ennesima volta, ci siamo soffermati sul fatto che il cliente volesse la “spettacolarizzazione della presa del gelato”. Da lì, a far nascere l’idea è stato un attimo!
Essere laici in advertising significa non escludere a priori nessun espediente, dai testimonial alla comedy, a seconda delle necessità. Lo abbiamo visto anche nell’ultimo lavoro per Amaro Montenegro. Ma i clienti sono disposti ad accettarlo, l’impressione è che pure loro si sentano tranquillizzati nel seguire trend più che tracciare un loro cammino. Sbaglio?
La laicità è un prerequisito necessario al nostro mestiere. Ne parlavo spesso con Maurizio D’Adda, con cui ho avuto la fortuna di lavorare quando ero in Young&Rubicam. Nel nostro mestiere non può esserci spazio per difese di ideologie, sentimenti snob o dottrine preconfezionate. Gli strumenti per costruire una buona comunicazione devono essere tutti a disposizione, guai ad avere solo mezza tastiera del nostro pianoforte. Si rischia di banalizzare il linguaggio, o di appiattirsi sui soliti toni.
Progetti in divenire, insomma cosa pianifichi per questo 2006?
Nel 2026 Mosquito continuerà a percorrere la strada tracciata, oggi resa ancora più stimolante dall’ingresso di nuovi clienti e dall’evoluzione del mio ruolo, anche come consulente. Vogliamo continuare a essere creativi, coraggiosi, inaspettati ma con i piedi saldamente per terra. Solo così potremo continuare a creare campagne che durino nel tempo e portare valore ai brand sui quali lavoriamo con tanta passione.
Infine una domanda rispetto all’industry, secondo te quale sarà il modello di agenzia vincente, alla luce dell’AI che impazza ma pure dell’esigenza di creatività che inizia a farsi impellente, della necessità di economie di scala e dimensione per servire business multinazionali, così come di non standardizzare e di avere un posizionamento differenziante?
Sul modello vincente di agenzia posso dire cosa mi auguro: che vincano le idee, il coraggio, i valori, le persone. E che questa crisi in cui siamo immersi serva a far girare più velocemente le rotelle di tutti. Oggi più che mai serve più ingegno e meno finanza, meno fatturifici e più agenzie capaci di sorprenderci ogni giorno. Infine, una nota sulla AI che spesso viene additata come una sorta di demone da cui guardarci. È evidente che il suo utilizzo e, soprattutto, la sua evoluzione porteranno tanti cambiamenti – e non tutti necessariamente positivi – con i quali dovremo fare i conti ma, essendo stata inventata dall’uomo, non vedo come potrà mai sopraffarci (tuttavia se qualcuno ha memoria di colpi di Stato o prese di potere da parte di altre invenzioni del passato – come il fax ad esempio – che al loro apparire lasciarono tutti sconcertati, sarò pronto a ricredermi).
di monica lazzarotto