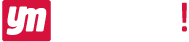Significa riportare tutto a una concorrenza di prezzo. Non a caso, il fiorire delle indipendenti, che dei loro brand vogliono tornare a fare il vero elemento differenziante. Utile però chiedersi dove stia il confine sostenibile tra valore e dimensione. La risposta? Nel significato.
“C’è una cosa che sta succedendo nel mondo della pubblicità globale e che, se non ci lavorate dentro, probabilmente vi è sfuggita. Ma è una di quelle cose che spiegano molto bene come funziona il capitalismo contemporaneo, ben oltre i confini di Madison Avenue.
Per farla breve: le grandi aziende che si fanno pagare milioni per costruire, proteggere e raccontare i brand degli altri, stanno distruggendo i propri. È un paradosso talmente evidente che nel settore se ne parla con un misto di incredulità e rassegnazione. Immaginate se la Ferrari, dopo aver acquisito la Lamborghini, decidesse di smettere di usare entrambi i marchi per vendere tutte le macchine sotto un nuovo nome generico, tipo “Auto Veloci S.p.A.”. Ecco, è esattamente quello che stanno facendo le grandi holding della comunicazione.
Un po’ di storia
Per capire perché sta succedendo, e perché è un problema, dobbiamo fare un passo indietro.
Cosa sono queste holding? Il mercato pubblicitario mondiale è dominato da pochissimi giganti. I nomi che contano sono sei (o meglio, lo erano fino a poco fa): WPP, Omnicom, Publicis, Havas, Dentsu e Interpublic Group (IPG). Queste non sono agenzie che fanno le pubblicità: sono enormi contenitori finanziari che possiedono centinaia di agenzie più piccole. Le agenzie “vere”, quelle che hanno fatto la storia della cultura pop del Novecento, sono quelle che stanno dentro questi contenitori. Parliamo di nomi mitologici come J. Walter Thompson (che ha praticamente inventato la pubblicità moderna nel 1864), Young & Rubicam, DDB (quelli della rivoluzione creativa di Volkswagen negli anni ‘60), TBWA o McCann. Questi nomi non erano solo etichette sulla porta. Erano culture, filosofie di lavoro, “tribù” in cui i creativi sognavano di entrare. Ognuna aveva il suo stile: se volevi l’eccellenza strategica andavi da una parte, se volevi la creatività folle andavi dall’altra.
Il grande “Ripulisti”
Negli ultimi anni, però, i CEO delle holding hanno guardato i loro bilanci e hanno fatto un ragionamento puramente finanziario (o da “Math Men”, come vengono chiamati oggi in contrapposizione ai vecchi “Mad Men”).
Hanno pensato: Perché pagare tre affitti, tre dipartimenti HR e tre direttori finanziari per tre agenzie diverse? Uniamole tutte». Il risultato è stata una strage di brand storici: WPP ha preso J. Walter Thompson (160 anni di storia) e l’ha fusa con un’agenzia digitale chiamata Wunderman. Poi ha preso Young & Rubicam e l’ha fusa con VML. Alla fine, non contenta, ha fuso tutto insieme creando VML. Un acronimo. Punto. Secoli di storia cancellati per tre lettere. Omnicom, più di recente, ha comprato IPG (un affare colossale da 13 miliardi di dollari) e ha deciso di “pensionare” marchi come DDB, FCB e MullenLowe, facendoli confluire in sigle più grandi o dismettendoli come entità autonome.
Perché è un paradosso (e un autogol)
Arriviamo al punto centrale. Queste aziende vendono ai clienti (come Coca-Cola, Ferrero o Nike) un principio sacro: il brand è tutto. Dicono ai clienti che bisogna investire per essere riconoscibili, che la storia conta, che l’identità è l’asset più prezioso. Eppure, applicano a sè stesse la logica opposta. Si comportano come il proverbiale calzolaio che va in giro con le scarpe rotte. Cancellando nomi come “Thompson” o “Rubicam” per sostituirli con sigle anonime, stanno dicendo implicitamente che in fondo nemmeno loro credono che il branding sia così importante e che le agenzie sono diventate delle commodity. Il messaggio è devastante. Se tutte le agenzie vengono fuse in un unico calderone indistinto, l’unico modo per distinguerle diventa il prezzo. E quando si compete solo sul prezzo, i margini crollano e la qualità del lavoro scende.
La fuga di chi ci lavora (e di chi compra)
Le conseguenze di questa “ingegneria finanziaria” si vedono su due fronti. Il primo è quello dei talenti. I creativi pubblicitari sono persone particolari, lavorano per orgoglio, per appartenenza. Vogliono giocare nel Real Madrid, non nella “Squadra di Calcio Holding S.p.A.”. Quando togli l’identità all’agenzia, i talenti migliori se ne vanno. E infatti stiamo assistendo alla nascita di una nuova ondata di agenzie indipendenti (come Uncommon o New Commercial Arts a Londra) fondate proprio da chi è scappato dalle holding. Il secondo fronte è quello dei clienti. I grandi brand cercano stabilità. Se la tua agenzia cambia nome, organigramma e referente ogni due anni perché c’è una nuova fusione decisa a New York, tu cliente perdi fiducia. Inoltre, c’è il problema del conflitto di interessi. Prima, una holding poteva gestire sia Ferrero che Barilla mettendoli in due agenzie diverse con culture e uffici separati. Ora che stanno accorpando tutto in enormi “megastrutture”, i clienti iniziano a chiedersi: «Ma il mio team creativo non è che sta parlando con quello del mio concorrente alla macchinetta del caffè?». (Brand all’ascolto: fidatevi che i vostri team parlano di tutto alla macchinetta del caffè, tranne che dei progetti di conquista del mondo dei clienti che seguono. Il vero tema è la separazione della conoscenza, dei file, dei vostri documenti all’interno dell’agenzia.)
Siamo a un bivio
Da una parte ci sono questi titani finanziari che stanno diventando sempre più grandi, efficienti e tecnocratici, ma anche sempre più anonimi e “senz’anima”. Dall’altra c’è un fiorire di realtà indipendenti, più piccole e agili, che stanno recuperando proprio quello che le holding hanno buttato via: la creatività, l’identità forte e il rapporto umano. Per un settore che vive di percezione, è una lezione brutale: puoi ottimizzare i costi quanto vuoi usando Excel, ma se distruggi il valore per cui i clienti ti pagavano, alla fine ti ritrovi con un foglio di calcolo molto ordinato e un ufficio molto vuoto.
Forse la domanda vera non riguarda le holding, né le sigle, né le fusioni. Riguarda il coraggio di scegliere cosa si vuole essere quando si cresce.
Perché ogni volta che un’organizzazione rinuncia al proprio nome, alla propria storia, alla propria voce, non sta solo semplificando una struttura, sta dicendo qualcosa su ciò che considera sacrificabile. Nel tempo in cui tutto tende a diventare scalabile, replicabile, indistinto, il valore non sembra più stare nella dimensione, ma nel significato. E il significato, a differenza dei costi, non si ottimizza: si custodisce. Chi lavora con i brand lo sa meglio di chiunque altro.
La parte interessante, ora, è capire chi avrà il coraggio di ricordarselo di fronte ai prossimi bivi imprenditoriali e manageriali”.
Tiziano Tassi, Ceo e Founder CAFFEINA.