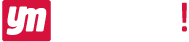di Ilaria Padovan, Client Manager Kantar
C’è rimasto qualcosa di cui chiedere, un’altra volta, ancora? In un contesto in cui l’informazione – che si esaurisce nell’essere immediatamente fruita – e i meme – poggiati sulle sabbie mobili della prima – hanno avuto la meglio sul racconto, fare la stessa esperienza due volte ha perso ogni significato.
Le stories di Instagram dissolte dopo ventiquattr’ore, la messaggistica a tempo, i funerali delle cornici perché le foto hanno senso di esistere solo su formati digitali dove verranno presto scalzate da nuove foto, più belle, più contemporanee, più rilevanti sono tutti sintomi del disincanto di cui Byung-Chul Han parla nella sua ultima opera ‘La crisi della narrazione’. Sono tutti i motivi per cui più che un ancora! speranzoso è più facile imbattersi in un ancora?! frustrato e già stanco di uno stimolo che non ha senso replicare. Eppure, qualcosa sopravvive: le risate. Dietro il successo del meme c’è questo, il divertimento: dopotutto, lo sappiamo, la dopamina ci ha vinti, tutti quanti. Ecco, di leggerezza, di risate – anche se sempre più sbiadite – sì che ne vogliamo ancora.
È il caso dei Cileni, quelli che, in realtà, erano gilet neri pieni di zucchero del brano Tuta Gold di Mahmood presentato a Sanremo. I Cileni di zucchero ci sono piaciuti, ci piacciono, ne vogliamo ancora, desideriamo che siano veri per poterne rubare un altro dal sacchetto senza che la mamma se ne accorga. Questi biscottini inesistenti sono uno degli esempi più fulminanti di come lo storytelling – votato al commercio e al consumo – sia profondamente dissimile dall’incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo, per dirla con le parole che Calvino riservava al racconto. I Cileni ci hanno fatto tornare all’infanzia, ci sono riusciti perché non ci hanno nemmeno provato e perché, dopotutto, siamo esseri umani e sappiamo che non basta preparare il soffritto per commuoverci: abbiamo bisogno di provare vere emozioni perché senza di esse il tempo è solo un incessante tic-tac. E questo i brand lo sanno. Questo, Mulino Bianco l’ha capito, tanto da averne inviato un pacco gigante al cantante con un’operazione di instant marketing da manuale.
Bisogna pur riconoscere che, per quanto meme durevole nei mesi, difficilmente tra vent’anni ci troveremo a dire te li ricordi i Cileni ripieni di zucchero? Improbabile che ne condivideremo il racconto con chi il Festival di Sanremo 2024 non l’ha vissuto. Dall’altro lato, certo è che Mulino Bianco farà ancora parte delle nostre vite, delle nostre colazioni, delle merende dei nostri figli, soprattutto, dei nostri ricordi, perché Mulino Bianco non è solo storytelling, non è solo un qualcosa con un logo sugli scaffali del supermercato o una pubblicità dentro a uno schermo, Mulino Bianco è un brand e, come tale, è intessuto alle fibre della nostra esistenza, come i bicchieri della nonna che erano tutti vasetti di Nutella reinventati a miglior servizio. I brand hanno la capacità e la forza di modificare le nostre quotidianità e da venire trasformati in un processo di dialettica hegeliana che si fonde con l’innata abilità del dimenticare a memoria di Agnetti: come la caratteristica più incredibile dei monumenti è quella di non essere notati, così la formula per l’imperitura memoria delle marche.
Sono la storia e l’immaginario ciò che rimane, ciò che è veramente in grado di definire il successo, perché, parafrasando di nuovo Byung-Chul Han, i valori non possono essere sfruttati solo dal mero punto di vista economico: lo sappiamo che non si cambia il mondo bevendo una tazza di tè, lo sappiamo che pensare di cambiare il mondo tramite il consumo è la morte della rivoluzione. Ecco dove i brand hanno successo: nel farsi portatori di valori universali, nell’essere una piattaforma aspirazionale, nel perorare cause che stanno a cuore all’intera società.
Non è un caso che, secondo Kantar Global Monitor 2023, tre quarti dei consumatori, a livello mondiale, si aspettino che le marche non si limitino a un impegno in ambito di sostenibilità ambientale, ma piuttosto a una presa di posizione e un impatto anche sul sociale e nemmeno che più di metà della popolazione globale si dica sempre più scettica relativamente ai claim apparsi su packaging e in pubblicità. Siamo alla ricerca di un’autenticità in grado di traghettarci verso un mondo migliorato e migliore. Sappiamo bene che questa è la rivoluzione di cui vogliamo fare parte, non il consumo.
Eccoci: incessantemente alla ricerca di un qualche cosa, spesso, se non proprio sempre, dell’autenticità. Ad un certo punto, abbiamo pensato di averla trovata, incarnata – letteralmente – nella figura degli influencer. Così vicini, così reali, così accessibili: com’era possibile che ci tradissero se la relazione si basava esattamente sul presupposto opposto? Ma l’abbaglio è stato a monte, quando si è preteso dall’influencer – nient’altro che una commodity digitale – che si facesse brand, quando non si è compreso che per essere autentici non basta, anzi, non serve proprio, essere umani. Ci siamo dentro, la stiamo attraversando l’epoca del de-influencing: finché ne possiamo ridere tutto bene – non è un pericolo chi non si può prendere sul serio – ma, di nuovo secondo Calvino, nulla piace agli uomini quanto avere dei nemici e vedere se sono proprio come ci s’immagina: il successo dell’influencer lo decreta la sua community, la sua sconfitta anche. Chiara Ferragni ne è diventata l’emblema del nemico che ora non ha più senso di esistere se non per subire umiliazioni. Tre milioni di spettatori all’intervista da Fabio Fazio e non nella speranza di vederla riabilitata. Come dalla puntuale analisi di Ester Viola su Lucy sulla Cultura, Chiara Ferragni ha fallito nell’incapacità di evolvere, nel rimanere incastrata in un ruolo che alla community, nemmeno alla sua, serviva più.
Quindi, tutto qui? No, perché l’errore è proprio a monte: sul medio-lungo periodo, saranno sempre i brand in grado di instaurare un legame emotivo con i consumatori e capaci di differenziarsi a crescere rigogliosamente, a crescere rigogliosamente. Nello scontro umano e non umano è più potente la marca. Al di là delle risorse, i brand sono in grado di esercitare un’influenza sulla vita, sui comportamenti e sui desideri delle persone ben lontani dalla semplicistica volontà di emulazione. Hanno un impatto culturale, semplificano ed evolvono le nostre quotidianità lanciando trend che non vivono solo dietro un hashtag. Al pari, se non meglio degli influencer, le marche sono riconosciute come autentiche e sono in grado di creare connessioni personali e dirette, sanno scatenare reazioni emotive profonde e durature, basti pensare al pitch di Mad Men per Kodak in cui Draper fa leva sulla nostalgia sapendo che il ruolo della marca non era quello di imprimere un’immagine su carta fotografica, ma di agire da macchina del tempo. Un’operazione non dissimile proprio da quella di Mulino Bianco con i Cileni di zucchero.
Preferiremo sempre i brand perché, appartenendo alla sfera del racconto, trascendono lo spazio ed il tempo, gli influencer, invece, rimangono un prodotto figlio di un’epoca che, forse, sta già volgendo al termine.