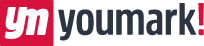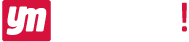“Napule è mille colori”, cantava Pino Daniele, e quella definizione si è legata indissolubilmente alla città. È invece una Napoli sorprendentemente in bianco e nero, come non l’abbiamo mai vista, quella che ci racconta in Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Premio Speciale della Giuria alla recente Mostra del Cinema di Venezia, e in arrivo nelle sale italiane dal 18 settembre con 01 Distribution. Gianfranco Rosi, ancora una volta, forse più delle altre, fa un film completamente inaspettato. A partire, appunto, dalla fotografia in bianco e nero che spoglia Napoli da ogni luogo comune e da ogni tono già visto, per arrivare a raccontare una città che vive della sua luce portandoci dove la luce non c’è. Dal cielo si passa subito alla terra per finire nel sottosuolo. Gli scantinati di un museo, gli anfratti delle tombe, il chiuso dei centri di controllo di emergenza.
Tante storie sotto il cielo di Napoli
Un maestro di strada dedica il suo tempo al doposcuola per bambini e adolescenti, i vigili del fuoco vincono le piccole e grandi paure degli abitanti, le forze dell’ordine inseguono i tombaroli. Una nave siriana, nel porto di Torre Annunziata, scarica il grano ucraino. Una squadra di archeologi giapponesi scava da vent’anni Villa Augustea: raccoglie semi, ossa, storie di sedimenti. I turisti vanno per le rovine di Pompei, i devoti strisciano nel santuario della Madonna dell’Arco, gli ex voto e le cripte raccontano il credo di un mondo che sopravvive. Eccole le storie di Napoli che non ci aspettiamo, ecco la gente comune, invisibile, che fa con devozione e in silenzio il proprio lavoro. Ecco chi non viene raccontato mai, ma che con Rosi trova finalmente spazio.
Gianfranco Rosi è immersione
Anche per raccontare Napoli, Gianfranco Rosi conferma il suo metodo di lavoro unico, immersivo. Rosi, come ogni volta, va a vivere a lungo nei posti che racconta, li assimila, li sente, li studia, si fonde con il territorio e con le persone. Si fida, e si affida a loro. E loro si fidano di lui. Solo così possono nascere i suoi racconti unici. “Ho girato e vissuto per tre anni all’orizzonte del Vesuvio”, racconta Rosi nelle note di regia, “cercando le tracce della Storia, lo scavo del tempo, ciò che resta della vita di ogni giorno. Raccolgo le storie nelle voci di chi parla, osservo le nuvole, i fumi dei Campi Flegrei. Quando filmo accolgo la sorpresa di un incontro, di un luogo, la vita di una situazione. La sfida del racconto è assecondare l’inquadratura, mentre le storie prendono vita. Il tempo del film è la fiducia di quell’incontro. Ho girato in bianco e nero, ho guardato in bianco e nero. Mentre filmavo, tra il mare il cielo e il Vesuvio, scoprivo un nuovo archivio del vero e del possibile”.
Il campo e il fuoricampo
Proprio grazie a quel bianco e nero la bellezza della città viene mostrata con eleganza e allo stesso tempo con pudore, come se non fosse mai ostentata, o mai rinchiusa in cliché e schemi preconfezionati. Ed è interessante anche come il film riesca a raccontare anche quello che, apparentemente non racconta e non mostra. Dalla radio e dalle telefonate ai vigili del fuoco, emergono le ansie per i pericoli vicini o lontani. “Tra la guerra e il terremoto che morte ci volete far fare per primi?” chiede al centralino dei pompieri una donna, con un’ironia amara che sembra uscita, come quella di molti altri interlocutori, da una commedia di Eduardo De Filippo. “L’inquadratura deve contenere anche quello che non si vede” gli aveva insegnato Bernardo Bertolucci che, nel 2013, lo aveva premiato qui con il Leone d’Oro per Sacro GRA. E così Sotto le nuvole racconta “una Napoli che ne contiene un’altra, in una continua ricerca del fuoricampo”.
Le persone comuni
Così si parla di microcriminalità a Napoli, ma fuoricampo. È la radio, con un notiziario, a farci sapere una serie di notizie sul fenomeno, mentre, con un’immagine a contrasto, un placido antiquario apre le serrande del suo negozio e si appresa a iniziare la sua giornata lavorativa. Così l’ombra delle guerre passa per un attimo nelle nostre teste mentre l’anziano maestro parla con i ragazzi del doposcuola che segue ogni giorno. Sotto le nuvole del bellissimo cielo di Napoli ci sono tante persone comuni, come queste, o quelle di cui sopra, fanno il loro lavoro quotidiano con fatica e con passione. Anche in questo modo Rosi ci mostra un volto inedito, poco battuto, di Napoli.
Illuminare ciò che non si vede
Tutto questo viene raccontato con un montaggio creativo, che lavora per analogie e affinità elettive. Dai famosi corpi carbonizzati e fissati in un attimo per l’eternità di Pompei si passa ai corpi plastici, anche questi fissati nell’eternità, delle antiche sculture classiche in marmo. È particolarmente affascinante il lavoro dell’archeologa del museo, quel suo dedicarsi alle opere che non sono esposte, quelle che non ce l’hanno fatta. Quel suo scrutare, con la luce di una torcia, e non con quella dell’impianto generale, per scoprire particolari che non appaiono a prima vista. Se ci pensiamo, è proprio il lavoro che fa Rosi con la sua macchina da presa. Scrutare, andare tra le pieghe, gli anfratti, cercare ciò che non si vede per illuminarlo e farcelo notare. Come spiega Rosi nelle note di regia, “tutti i personaggi incontrati nel film sono devoti a qualcosa: un’idea, una verità, un gesto, una memoria. La devozione non ha connotati religiosi nel senso stretto, ma assume un carattere rituale, a tratti sacrale. È una forma di abbandono e, al tempo stesso, di resistenza”.
Una riflessione sulla memoria
Sotto le nuvole è anche una riflessione sulla memoria, che può essere vista in vari sensi. La memoria è nei reperti storici, che la conservano per millenni e la fanno arrivare a noi. Ma è anche nelle immagini. Come nelle fotografie delle opere che vediamo fare al museo. E nei filmati d’archivio, che Rosi usa come “coro”, come commento, e come controcampo al girato del suo documentario. Li vediamo proiettati in vecchi cinema dismessi. E uno di questi, uno spezzone di Stromboli, di Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman, è emozionante. “Le sale cinematografiche abbandonate puntellano il film, tracce di una memoria collettiva: le immagini d’archivio, senza spettatori in sala, per altre vie giungono sino a noi, documenti di scelte e abitudini, contrappunto del presente” ha spiegato Rosi. Come detto, anche il museo ha un senso profondo. “Il museo MANN è luogo emblematico e archivio vivente di un mondo cancellato dal vulcano, e al tempo stesso stratificato sopra un altro mondo ancora vivo: il mondo romano, arcaico, pagano. Passato e presente sono più che archeologia e storia”.
Incontri che intrecciano le storie
Come in ogni sua opera, Rosi si affida a delle persone, ne fa le sue “guide” e si fa portare in giro da loro. “L’ incontro emotivo è mediato dalla cinepresa e la fiducia è il tempo che si dedica ai propri personaggi” ha spiegato. “Filmare è l’ultimo passo da fare per confermare un legame. Mi sento a volte come un nomade con la macchina da presa: come uno straniero che viene accolto dai suoi personaggi, che diventa complice delle storie che raccontano dinanzi all’obiettivo. Nel montaggio le storie si sono intrecciate, i gesti e le parole di ciascuno sono diventate la trama delle parole e dei gesti degli altri. Ho cominciato a montare mentre filmavo. Ho vissuto il montaggio come una riscrittura capace di accompagnare il film mentre era ancora in divenire. Le persone, i luoghi, le azioni, li ho visti nella lente della macchina da presa e, quasi contemporaneamente, sullo schermo nella sala di montaggio”.
Un antidoto alla vita troppo veloci di oggi
Questo affidarsi alle persone è la forza e il limite del film. Il suo seguire e intrecciare le vite di queste persone permette al film di avere più fili conduttori. Ma, a tratti, rischia di rendere l’opera ripetitiva nel suo racconto. Ma quel suo indugiare più volte, per un tempo forse più lungo di quello che si saremmo aspettato, su queste persone, queste vite, queste storie, è probabilmente anche un atto di resistenza, come lo è tutto il modus operandi di Rosi. Fermarsi tre anni in un luogo, raccogliere in maniera certosina le immagini – proprio come fanno gli archeologi giapponesi con i reperti di Pompei – custodirle, fermarsi a raccontare con tempi lunghi è un antidoto a tante cose di oggi. A partire dalla nostra vita troppo veloce, all’informazione mordi e fuggi, ai video di 30 secondi su TikTok, a quelli creati con l’Intelligenza Artificiale. Avercene, oggi, di artisti come Gianfranco Rosi.
di Maurizio Ermisino