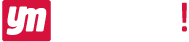“Per paura degli uccelli canori del santo mese dell’Ade”. Che cosa significano queste misteriose parole? Lo scopriremo solo vivendo, anzi vedendo L’orto americano, il nuovo film di Pupi Avati, presentato al Festival di Venezia e ora nelle sale dal 6 marzo con 01 Distribution. È un film che, anche se solo per una parte, riporta Pupi Avati in America, nello Iowa dove aveva girato Bix, l’America dove nella sua carriera è tornato spesso, vedi film come Fratelli e sorelle e L’amico d’infanzia. È un film orgogliosamente d’altri tempi, in bianco nero, ambientato negli anni Quaranta. Un film che vede il ritorno di Pupi Avati all’horror, pur sfuggendo ai generi.
Da Bologna verso l’Iowa
È la storia di un ragazzo di Bologna che, mentre è dal barbiere, incontra per un attimo una giovane infermiera dall’esercito americano che gli chiede un’indicazione per Ferrara. Da uno scambio di sguardi si convince che è l’amore della sua vita. Il caso vuole che, per uno scambio di case, si trasferisca in Iowa per provare a scrivere il suo romanzo, il primo che forse sarà pubblicato. Lega con la sua vicina di casa, una signora anziana, nella cui casa ritrova la foto di quella ragazza americana. È Barbara, sua figlia, ed è scomparsa. Nell’orto, poi, trova qualcosa…
Sospensione dell’incredulità e incedere ipnotico
Come si capisce, la storia de L’orto americano si basa su una concatenazione di eventi così fortuiti e assurdi che ci richiede un’enorme sospensione dell’incredulità. Eventi che, nel sottofinale e nel finale, arrivano anche a dei voli pindarici (proprio Pindaro, per un attimo, entra nella storia). Ma è un film che tiene incollati allo schermo grazie a un incedere ipnotico e un’aura magnetica che conquista.
Hitchcock e Neorealismo
Gran parte del fascino de L’orto americano è dovuta alla sua forma visiva, un bianco e nero elegante, contrastato, che fa sembrare l’ultima opera di Avati davvero un film uscito dagli anni Quaranta. “Il bianco e nero lo debbo a mio fratello che una volta letto il copione ha detto ‘questo è un film in bianco e nero’” ci ha raccontato Avati a Roma. “È stata la chiave di volta di un approccio che è mutato. Non avevo mai sperimentato questa esperienza di tradurre la realtà a colori in qualcosa che non è più a colori e non è più realtà. Ma è il cinema. Girando in America ci sono stati dei riferimenti a Hitchcock e a Fonda. Poi, in Italia, improvvisamente ecco il Neorealismo del primo dopoguerra. Il bianco e nero era legittimato”.
Il suono di un theremin? No, è una sega…
A queste atmosfere giova anche la particolarissima colonna sonora d’altri tempi. Ci sembrerebbe il suono di un theremin, ma è uno strumento molto particolare. “Questo modo di girare ci ha influenzato fortemente, ci ha portato a una serie di citazioni che si estendono anche al sonoro” spiega. “Lo strumento era una sega da falegname, suonata da un archetto che scorre su una lama. Il riferimento è a La scala a chiocciola”.
Il ritorno del genere
L’orto americano è un film che viaggia tra i generi. All’inizio sembra un melò, poi diventa un thriller, sembra una ghost story e poi per una parte diventa un legal thriller. Per svelare infine la sua natura di horror, ma dal taglio molto particolare. È quell’horror padano che Pupi e Antonio Avati hanno codificato, molto tempo fa, con il film seminale La casa delle finestre che ridono, che negli anni ha assunto l’aura di vero e proprio cult. “È un genere che non abbiamo mai tradito del tutto” ragiona Avati. “Abbiamo aperto finestre a incursioni a un cinema più intimo autobiografico, ma senza dimenticare che il genere ha fatto forte il cinema italiano: Argento, Fulci, Bava, che sono tutti morti. Anzi, Argento no… Il cinema italiano ormai fa i film del genere di se stesso: Sorrentino fa il film di genere Sorrentino. Amelio fa i film di genere Amelio…”
Il protagonista è Filippo Scotti
A proposito di Sorrentino, Pupi Avati (che ha riportato in scena molti degli attori che ama, come Massimo Bonetti, Chiara Caselli, Andrea Roncato e Nic Nocella) ha scelto come protagonista il giovane Filippo Scotti, il Fabietto di È stata la mano di Dio. Un volto interessante che si trova a suo agio sia nella Napoli degli anni Ottanta, che nella pianura padana degli anni Quaranta. Scotti è entrato in corsa nel progetto, a dieci giorni dall’inizio delle riprese. “Ma le cose le facciamo così col cuore che arriva un’energia forte” ci racconta. “Pupi Avati mi ha incontrato e mi ha detto iniziamo tra una settimana e tu devi sentirti amato”.
Un’agenzia italiana per il cinema
Il bello di incontrare Pupi Avati non è solo nel parlare dei suoi film, ma anche di altro. Siamo tornati infatti a discutere sulla sua idea di un Ministero del Cinema. “La mia proposta bipartisan è stata accolta sia da una parte del governo, Tajani per Forza Italia, sia dalla parte di Schlein e Franceschini” ci aggiorna. “Invece che un ministero hanno in mente un’agenzia sul modello di quella francese, che sarebbe una cosa serissima e assolutamente opportuna. Si è parlato della chiusura di 160 sale a Roma. Ma il problema sono le produzioni in difficoltà e il ministero che ha molti soldi da dare. Un ministero che non si può occupare delle feste di paese, della lirica e del cinema. Il ministro Giuli pensa che sia opportuno”.
Un corso per fare film a basso costo
“Il nostro paese è in difficolta e non può avere un cinema dai budget hollywoodiani” ci dice Avati. Che ci tiene anche a ribadire come il suo film abbia avuto un budget molto molto ragionevole, cosa che molti film italiani oggi non hanno. Serve, insomma, un ritorno a un cinema dell’essenziale. E il buon Pupi anche qui ha una sua proposta. “Al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove sono consigliere, sto promuovendo una cattedra, una docenza di basso costo: dove si insegna a produttori, sceneggiatori e registi a fare un film dove non manca nulla, con budget contenuto, che può andare a Venezia. È un grande problema della filiera del cinema italiano: molti film usciti quest’anno erano fuori budget”.
di Maurizio Ermisino