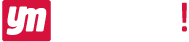Si apre con All Apologies, una struggente canzone dei Nirvana, nella versione cantata da Sinead O’Connor, Queer, l’atteso film di Luca Guadagnino, presentato allo scorso Festival di Venezia e in arrivo nelle sale italiane dal 17 aprile. Quella canzone è la prima sorpresa del film, l’ennesimo segnale che nel cinema di Luca Guadagnino non c’è mai nulla di scontato, non si percorre mai una strada già battuta. Il regista di Chiamami col tuo nome e Challengers qui sceglie di adattare per il grande schermo il romanzo omonimo di William Burroughs e lo fa con un protagonista iconico come Daniel Craig, che porta in territori ancora inesplorati nella sua carriera. È il 1950. William Lee è un americano di cinquant’anni espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. L’incontro con Eugene Allerton, un giovane studente appena arrivato in città, lo illude per la prima volta della possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno. Queer è un film affascinante ma non facile, uno di quei racconti senza svolte drammaturgiche ad effetto, ma un’opera ipnotica, avvolgente, atmosferica. Dove non contano le azioni ma le sensazioni. È un film che in qualche modo, dopo la sua fine, rimane appiccicato addosso.
Burroughs: una lingua deflagrante, provocatoria e libera
Ma perché William Burroughs? E come ha scoperto il romanzo Queer Luca Guadagnino? “Il libro l’ho letto in maniera causale” racconta. “Ma non c’è mai nulla di casuale. È come se fosse venuto da me nel 1988: avevo 17 anni ed ero a Palermo, e l’ho scoperto nella libreria Sellerio. Il nome Burroughs per me aveva qualcosa di potentissimo. Raccolsi i soldi per comprare quel libro e rimasi colpito dalla forza immaginifica della parola di Burroughs. Sarebbe facile dire che, da giovane omosessuale, mi avesse colpito il tema del libro. Ma in realtà era perché usava una lingua deflagrante, provocatoria e libera”.
Detective story
Luca Guadagnino e gli sceneggiatori hanno fatto un grande lavoro sul testo, andando a cercare nelle sue parole il filo nascosto, il segreto di Burroughs. “Il tema del libro era la fragilità amorosa di Burroughs, il dolore profondo dell’amore che ha provato” commenta il regista. “E anche quello che ha provato Anderton, non essendo stato libero di riconciliare questo desiderio con la sua capacità di essere. Entrambi sono vinti da questo gioco a scacchi. Il libro è una macchina di illustrazione della repressione interiore di questi personaggi, che ci lascia, come in una detective story, tutti gli indizi per capire che dietro la repressione c’è questo desiderio sconfinato l’uno per l’altro”.
Spogliare Daniel Craig dagli abiti di 007
La grande sfida di Luca Guadagnino in Queer è spogliare Daniel Craig dalle vesti e dall’immaginario di James Bond, ruolo che lo ha reso iconico. L’operazione è riuscita alla perfezione: Craig è credibilissimo come William Lee. Sudato, con i capelli più lunghi del solito attaccati alla fronte, la barba non fatta e le occhiaie, Craig dà l’idea di un uomo stanco, provato, solo. È in scena con vesti leggere, di lino o di cotone bianco, quelle adatte ai quei climi e quei tempi. Lo vedremo anche senza nulla addosso, con il corpo statuario e vissuto, protagonista di scene molto forti. Non c’è un momento in cui pensiamo che sia stato l’agente 007. Craig è già oltre questo ruolo. “Ho cercato di costruire la mia carriera sempre guardando avanti e mai indietro” ha raccontato. “Quando interpreto una parte deve essere il mio qui e ora. Cerco di dedicarmi anima e corpo a quello che faccio. La recitazione, per la sua stessa natura, è un’esperienza fuggevole che scompare. Io devo andare avanti e pensare oltre. Non significa che alla fine di un lavoro come questo uno non si senta esausto emotivamente. Ma è un senso di stanchezza bello, che ti permette di dedicarti a un nuovo progetto”.
Un ponte con la generazione del grunge e la Gen Z
Sentire i Nirvana, anche nella versione di Sinead O’Connor di un loro brano, i New Order, e poi i nostri Verdena, ma anche Prince, in un racconto come questo è sorprendente. È un cortocircuito. È un salto nel vuoto. La Città del Messico degli anni Cinquanta, la Manchester degli anni Ottanta e la Seattle degli anni Novanta sono lontane, eppure queste canzoni sembrano avere perfettamente senso. Un senso che si trova probabilmente nello spleen, in un male di vivere che anima Queer come la musica di questi artisti. “La musica è come un personaggio che si mette in discussione con gli altri, che fa corpo a corpo con le performance degli attori. Abbiamo molta musica che arriva dal juke-box, dalle musiche del momento, che parla di quel luogo storico. Ed è arrivata l’intuizione: sapevamo che Kurt Cobain, artista immenso che ha vissuto con un dolore cosmico, era così vicino a William Burroughs, idealmente e non solo, visto che lo conobbe. Ho voluto gettare questo ponte che univa questo guru fuori dal tempo con la generazione del grunge. E con una band che è sentita molto anche dalla Gen Z. Abbiamo fatto in modo che il dolore profondo che risuona nell’urlo di Kurt Cobain potesse diventare il partner emotivo di questi personaggi. Ci siamo chiesti, a proposito dei Nirvana: da dove vengono e dove sono andati? Abbiamo pensato ai New Order e i Verdena. Che in America tanti amano.
Hopper, Lynch, Cronenberg e una grande regia
Una delle chiavi del film sembra essere la fascinazione per la gioventù che era quella del Gustav von Aschenbach de La morte a Venezia di Thomas Mann. A volte sembra vedere i quadri di Hopper, a volte dei momenti del cinema di Lynch e Cronenberg, di cui Guadagnino è un cultore. “Cronenberg non ha mai fatto film sui mostri ma sulla inesorabile fragilità della natura umana” commenta, tornando sul filo conduttore del discorso. “La Mosca era una storia d’amore”. Anche Queer è una storia d’amore. È un film di attori, di atmosfere. Di scenografie (la Città del Messico degli anni Cinquanta è riscostruita completamente, e mirabilmente, da noi, a Cinecittà). Ma è anche e soprattutto un film di regia. Una delle sequenze più belle è la mano di Lee che accarezza il volto del giovane Eugene, non ancora conquistato, in dissolvenza, mentre in realtà non accade. È il desiderio non ancora realizzato. Così come colpisce quella in cui, mentre vede una tv dal segnale disturbato, il William Lee di Craig, che è fuori dall’immagine televisiva, appare con un’immagine segnata da disturbi. È da questi particolari che si giudica un grande regista.
La torsione bigotta della politica americana è preoccupante
Un artista che è tra i pochi che lavora regolarmente nel cinema americano. E allora è immediato chiedergli come stia cambiando l’America di oggi. “Nel modo in cui i miei film sono stati finanziati e distribuiti sono state messe in atto tutte le politiche che si possano definire di diversità e inclusione” spiega Guadagnino. “Questa torsione bigotta della politica statunitense è preoccupante. Il mio prossimo film non avrà in alcun modo timore di continuare nella direzione e nella ricerca in cui vado: far vedere ogni forma di personalità che possa esprimersi in un sistema complesso come quello che è un film”.
di Maurizio Ermisino